Lo so, devo morire, qualcuno mi ha dato dell’acqua tofana.
Queste le parole che un sofferente Mozart pronuncia su una panchina del Prater di Vienna rivolgendosi alla moglie Constanze Weber, forse sperando in un suo ripensamento. Che Mozart fosse stato avvelenato non è provato, certo è che il compositore austriaco si spegnerà nel 1789, due anni dopo aver pronunciato queste parole, lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro: il Requiem.
Questo particolare episodio – così come la citazione che ne fa Alexandre Dumas in Il conte di Montecristo – testimonia quanto fosse popolare, anche a distanza di secoli dalla sua “messa in commercio”, l’acqua tofana. Si trattava di un potentissimo veleno a base di arsenico con la caratteristica di essere inodore, incolore e del tutto simile a della comune acqua.
A inventare il veleno, o meglio ad affinarlo, fu Giulia Tofana. Nata a Palermo, probabilmente negli anni a cavallo tra il 1500 e il 1600, Giulia era figlia d’arte. Da quello che si è riuscito a ricostruire, sembra infatti che sua madre fosse Tofania d’Adamo, giustiziata nel 1633 con l’accusa di aver avvelenato il marito Francesco.
Rimasta orfana, Giulia dovette adattarsi a vivere nel malfamato quartiere del Papireto a Palermo, tra piccoli furti e prostituzione. Determinata a fuggire da quella vita di miseria, Giulia iniziò a lavorare alla “ricetta di famiglia”.
Seppure analfabeta, la ragazza aveva una vivace intelligenza e dopo alcune prove riuscì a migliorare la miscela ideata dalla madre, ottenendo così il veleno perfetto. L’acqua tofana, oltre a non presentare nessun odore o sapore, uccideva lentamente, senza sintomi o segni evidenti che potessero far sospettare un avvelenamento. A seguito del "trattamento all’acqua tofana", alla sua morte la vittima conservava un roseo colorito che faceva pensare a un decesso per cause naturali. Per non attirare sospetti su di sé, l’omicida doveva avere però pazienza, la somministrazione doveva avvenire un po’ per volta: solo poche gocce al giorno nel vino o nella zuppa.
E un così prodigioso prodotto conobbe presto il successo che meritava. Giulia aveva però saldi principi morali: spacciato come cosmetico femminile, l’acqua tofana veniva venduta solo a quelle donne che, costrette in un matrimonio infelice, volevano liberarsi del proprio marito. Seppure vivessero una condizione leggermente più favorevole rispetto al periodo del Rinascimento, la situazione femminile era infatti ancora disastrosa. Costrette a prendere marito in giovane età e spesso maltrattate, le donne avevano un solo modo per tornare a riappropriarsi della propria vita: diventando vedove.
Non passò però molto tempo prima che Giulia attirasse su di sé l’attenzione della Santa Inquisizione. Una delle sue clienti non seguì le indicazioni circa la somministrazione del veleno e il marito, scoprendo il tentativo di avvelenamento, denunciò Giulia. Per sottrarsi alle indagini, l'avvelenatrice fu costretta a fuggire da Palermo. Grazie all’aiuto di un prelato divenuto suo amante, tale frate Girolamo, la donna trovò rifugio a Roma dove visse negli agi dimentica della sua precedente professione per molto tempo… almeno fino a quando un’amica non le chiese aiuto raccontandole di quanto fosse violento suo marito. Giulia non si tirò indietro dimostrando che quella che era partita come una redditizia professione, era ora diventata una vera e propria missione.
Vivendo ora protetta da un prelato, Giulia riuscì a reperire ancora più facilmente tutti gli ingredienti necessari a realizzare l’acqua tofana. L’avvelenatrice era quindi tornata in affari e le nobildonne romane non mancarono di rispondere al suo appello.
Ma ancora una volta una cliente “sbadata” mise nei guai Giulia. Sembra infatti che la contessa di Ceri, ansiosa di liberarsi del marito, invece di seguire le indicazioni di Giulia, svuotò l’intera boccetta di acqua tofana nella zuppa, provocando la morte immediata dell’uomo e scatenando i sospetti dei parenti del defunto. Torturata, la contessa confessò ogni cosa, compresa la complicità di Giulia.
Arrestata, durante il processo, l’avvelenatrice palermitana confessò di aver venduto una quantità di veleno sufficiente a uccidere 600 uomini nel solo periodo in cui visse a Roma, tra il 1633 e il 1651. Condannata a morte, fu giustiziata nel 1659 a Campo de’ Fiori. La sua fama però le sopravvisse, come probabilmente anche la gratitudine di molte delle donne che aveva aiutato.


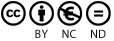





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
